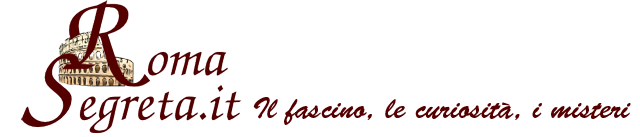La Basilica di S.Giovanni dei Fiorentini (nella foto sopra), situata all’estremità di Via Giulia tra Piazza dell’Oro e Lungotevere dei Fiorentini, fu costruita per la numerosa comunità fiorentina che viveva in questa zona, supportata dal potere di due grandi papi toscani di casa Medici, Leone X e Clemente VII. La comunità arrivò ad avere un proprio tribunale, proprie leggi, un Console con relativo Consolato ed addirittura un proprio carcere. Leone X, con bolla del 29 gennaio 1519, concesse all’Università della Nazione Fiorentina e Compagnia della Pietà di Roma l’antica chiesa di S.Pantaleone juxta flumen, annoverata tra le filiali di S.Lorenzo in Damaso nella bolla di Urbano III del 1186, sottoposta nella bolla di Onorio III del 21 maggio 1218 alla chiesa dei Ss.Celso e Giuliano, avendo ivi i fiorentini la loro residenza, i loro banchi ed il loro Consolato. I fiorentini demolirono quindi la chiesetta di S.Pantaleone e costruirono una splendida chiesa che dedicarono al patrono di Firenze, S.Giovanni Battista. Fra i disegni presentati, tra gli altri, da Michelangelo, da Raffaello e da Baldassarre Peruzzi, il pontefice scelse quello di Jacopo Sansovino, che iniziò la costruzione nel 1519.

La chiesa richiese un secolo per essere completata e fu continuata, infatti, da Antonio da Sangallo il Giovane, da Giacomo Della Porta e da Carlo Maderno, al quale si deve la caratteristica cupola di forma allungata, per cui i romani la battezzarono “il confetto succhiato” (nella foto 1). La cupola si imposta su un alto tamburo ottagonale sul quale si aprono quattro finestre rettangolari, con eleganti cornici, ed altrettante nicchie ad arco. Sopra, dopo una zona intermedia leggermente arretrata, si eleva la calotta, scandita in sezioni ogivali, che si conclude con una graziosa lanternina barocca finestrata. Nel campanile venne posta un’antica campana con la scritta in inglese Maria is my name che si vuole provenga dalla Cattedrale di S.Paolo di Londra.
La facciata della basilica è in travertino e fu eretta dall’architetto fiorentino Alessandro Galilei nel 1734, come indicato sulla grande iscrizione sovrastante l’ingresso centrale: CLEMENS XII PONT(IFEX) MAX(IMUS) A(NNO) S(ALUTIS) MDCCXXXIV, ovvero “Clemente XII Pontefice Maximo nell’Anno della Salvezza 1734”.

La maestosa facciata presenta tre portali d’ingresso, corrispondenti alle tre navate interne, i quali sono inquadrati da otto semicolonne con capitelli in stile corinzio: due laterali, sormontati da finestre quadre e con timpano semicircolare, ed uno centrale, con timpano triangolare e sormontato da un gruppo scultoreo (nella foto 2) al centro del quale svetta un grande stemma di Papa Clemente XII Corsini affiancato da due statue raffiguranti la Carità e la Fortezza realizzate da Filippo Della Valle. Le semicolonne inquadrano quattro nicchie centinate sopra le quali sono collocati altrettanti rilievi eseguiti intorno al 1735 e raffiguranti Storie della vita di S.Giovanni Battista: la Visitazione di Paolo Benaglia, il Battesimo di Gesù Cristo di Pietro Bracci, S.Giovanni Battista predica nel deserto di Filippo Della Valle e la Decapitazione di S.Giovanni Battista di Domenico Scaramuzzi.
L’ordine superiore presenta un grande finestrone centrale con balaustra marmorea e timpano semicircolare inquadrato da quattro semicolonne. L’attico è ornato da sei statue di santi e beati fiorentini: a sinistra vi sono le statue di S.Maria Maddalena de’ Pazzi di Salvatore Sanni, S.Filippo Benizi di Francesco Queirolo ed il Beato Pietro Igneo di Simone Martinez; a destra le statue di S.Bernardo degli Uberti di Gaetano Altobelli, S.Eugenio di Firenze di Pietro Pacilli e S.Caterina de’ Ricci di Giuseppe Canard. Un grande timpano triangolare conclude la facciata.

L’interno (nella foto 3), a pianta basilicale, è diviso in tre navate da due file di pilastri in muratura e presenta cinque cappelle per lato.

All’incrocio tra la navata centrale ed il transetto s’innalza la semplice ed elegante cupola (nella foto 4) che presenta, nella calotta, la Colomba dello Spirito Santo e nella cornice l’iscrizione dedicatoria che così recita: DEO ET S(ANCTO) IOANNI BAPTISTAE NATIO(NIS) FLOR(ENTINORUM) DE URBE A(NNO) MDCXIIII, ovvero “A Dio e a S.Giovanni Battista della Nazione dei Fiorentini di Roma nell’Anno 1614” .

Il presbiterio, disegnato da Pietro da Cortona nel 1634 ma realizzato oltre 20 anni dopo da Francesco Borromini, presenta il meraviglioso gruppo marmoreo raffigurante il Battesimo di Gesù Cristo (nella foto 5), eseguito nel 1669 da Ercole Antonio Raggi.

La basilica custodisce la Tomba di Francesco Borromini, come avverte l’epitaffio (nella foto 6) murato sul terzo pilastro di sinistra della navata centrale, qui sepolto insieme a suo zio Carlo Maderno (nella foto 7 i due sepolcri).

Come si sa, il Borromini morì suicida nel 1667, gettandosi sulla spada che lo trafisse da parte a parte: la sepoltura in un luogo consacrato, però, non deve stupire perché l’artista, agonizzante per due giorni, accettò i Sacramenti e si pentì del gesto compiuto, dovuto alla grave malattia che da tempo lo affliggeva. Nonostante il pentimento, però, la tomba allestita nella cripta di S.Carlo alle Quattro Fontane rimase vuota perché i Trinitari non permisero che nella loro chiesa vi fosse sepolto un suicida.

Nella terza cappella della navata sinistra è situato il gruppo scultoreo raffigurante il Battesimo di Gesù Cristo (nella foto 8), realizzato in marmo nel 1634 da Francesco Mochi per il presbiterio di S.Giovanni dei Fiorentini su commissione della famiglia Falconieri: probabilmente la scultura non piacque molto ai committenti tanto che non fu mai posta nella chiesa ma trasportata a Palazzo Falconieri. Nel 1825, nell’ambito dei lavori diretti da Giuseppe Valadier per il restauro di Ponte Milvio, le due statue furono divise ed utilizzate per ornare i due piedistalli posti ai lati della torretta del ponte. Nel 1955 il gruppo venne trasferito a Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma, per un lavoro di restauro, ma in realtà vi rimase fino al 2016 quando fu deciso di riportarlo nella collocazione per la quale era stato progettato, ovvero nella Basilica di S.Giovanni dei Fiorentini. Un’ultima precisazione: le due statue del Battesimo di Gesù Cristo che oggi ornano Ponte Milvio sono copie che vi furono collocate nel 2001.
Da segnalare infine la prima cappella a destra dell’ingresso, dove una lapide latina indica il sepolcro dei Marchesi del Grillo: qui sono sepolti, infatti, Cosma (1711), Bernardo (1757) ed Onofrio del Grillo (1787), ispiratore del celebre film Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli ed interpretato da Alberto Sordi.
La basilica, conosciuta anche per accettare la presenza degli animali durante la Santa Messa, fu eretta a parrocchia da Pio X con la costituzione apostolica Susceptum Deo inspirante del 24 ottobre 1906, che operò il trasferimento dalla chiesa dei Ss.Celso e Giuliano del capitolo canonicale e dei diritti parrocchiali. Benedetto XV, con breve del 19 agosto 1918, la decorò del titolo di Basilica Minore e Giovanni XXIII la elevò a titolo cardinalizio presbiterale il 14 marzo 1960.
> Vedi Cartoline di Roma