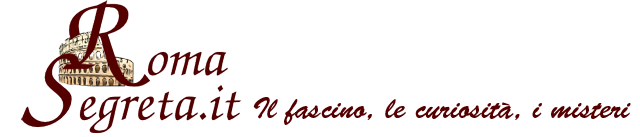Le pendici del Pincio cominciarono a popolarsi di ville verso la fine dell’età repubblicana. È incerto se in questa zona vi fossero quelle di Scipione Emiliano e di Pompeo, mentre nessun dubbio può esistere per quella di Lucullo, costruita subito dopo il trionfo nel 63 a.C. su Mitridate, con le immense ricchezze tratte dal bottino. Gli Horti Luculliani occupavano le pendici della collina, con una serie di terrazze alle quali si accedeva tramite scalee monumentali: la parte più alta, alla quale si perveniva da una scalinata trasversale a due rampe, era conclusa da una grande esedra, al di sopra della quale vi era un edificio circolare, identificato come un tempio dedicato alla Fortuna. La villa doveva ergersi invece in fondo alla via antica, corrispondente a Via dei Condotti, pressappoco nella posizione della chiesa di Trinità dei Monti. In seguito, questa magnifica villa passò in proprietà di Valerio Asiatico, il quale fu costretto da Messalina, che voleva impadronirsene, a suicidarsi. Da allora (46 d.C.) la villa entrò a far parte del demanio imperiale. Della grandiosa Villa di Lucullo i pochi resti ancora visibili si trovano nei sotterranei del Convento del Sacro Cuore e sotto Villa Medici. Nel II e III secolo gli horti erano proprietà della gens Acilia, anche se la loro villa, e quelle più tarde degli Anicii e dei Pincii (che diedero il nome al colle), dovettero occupare la parte più settentrionale della collina.

Un resto delle loro sostruzioni è il cosiddetto Muro Torto (nella foto 1), databile alla fine dell’età repubblicana e che fu poi incluso nella cinta delle Mura Aureliane. Fu chiamato anche Muro Malo perché vi venivano sepolti i defunti impenitenti e le prostitute di basso rango. Qui furono sepolti anche Targhini e Montanari, decapitati nel 1825 a Piazza del Popolo, tanto che si narrava che i due passeggiassero sul muro con le teste fra le mani, regalando ai passanti i numeri vincenti del Lotto. Il luogo veniva anche indicato come Sepolcro di Nerone, tanto che nella Pianta di Roma del 1593 veniva indicato come Sepulcrum Neronis alias Muro Torto: anche in questo caso la leggenda vuole che il fantasma di Nerone vagasse fra le mura. Da segnalare che l’edificio simile ad una torre visibile a sinistra nella foto 1 custodiva gli ascensori del Pincio, un servizio purtroppo non più in funzione, che permetteva ai romani di arrivare con un tram alla base dell’edificio su Viale del Muro Torto e di salire al Pincio senza alcuna fatica. L’impianto, costituito da due ascensori, fu inaugurato nel 1926 e rimase in servizio fino al 1960. La sistemazione del Pincio, anticamente chiamato anche Collis Hortulorum, il Colle degli Orti, per il gran numero di orti e vigne che ospitava, fu compiuta radicalmente nel 1811 da Pio VII, su progetto di Giuseppe Valadier: gli ampi viali fiancheggiati da pini domestici, palme e querce sempreverdi divennero ben presto un posto alla moda per passeggiare.
Una caratteristica del Pincio sono senz’altro i 229 busti di personaggi celebri della storia disseminati lungo i viali (nella foto sotto il titolo), i cui nasi, purtroppo distrutti regolarmente ed a più riprese da vandali, vengono ogni volta risistemati tramite un’accurata plastica facciale ad opera degli esperti restauratori capitolini. Nel 1849 il governo di Pio IX venne rovesciato dalla Repubblica Romana e così, per dare un aiuto economico ai molti artisti disoccupati, il Triumvirato composto da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini ed Aurelio Saffi stanziò un fondo di 10.000 lire per la creazione di busti in marmo di personaggi famosi della storia d’Italia per decorare i giardini del Pincio. Dopo pochi mesi, però, il governo pontificio tornò in carica e così i 52 busti già realizzati finirono nei magazzini comunali. Nel 1851 Pio IX, impegnatosi in una serie di lavori di rinnovamento urbanistico, decise di riutilizzare i busti, ad eccezione di quelli considerati rivoluzionari, eretici o semplicemente contrari al potere temporale del pontefice. Particolarità degna di nota è il fatto che alcune statue “cambiarono sembianze”: infatti nel 1860 i busti “censurati” furono consegnati a scultori affinché ne modificassero i lineamenti e così Giacomo Leopardi venne trasformato nel pittore dell’antichità Zeusi, Niccolò Machiavelli divenne Archimede, Vittorio Alfieri divenne Vincenzo Monti, Paolo Sarpi divenne Pier Luigi da Palestrina e Girolamo Savonarola venne trasformato in Guido d’Arezzo. Dopo la caduta dello Stato Pontificio avvenuta nel 1870, il Comune di Roma divenne l’unico responsabile dei busti ed il loro numero aumentò considerevolmente nel tempo tanto che alla fine degli anni Sessanta i busti erano 228, dal 1º gennaio 2012 divenuti 229.

Iniziamo la visita percorrendo il Viale Gabriele D’Annunzio che da Piazza del Popolo si inerpica verso il colle: qui, all’altezza di un’ampia curva a sinistra, è situata una fontana (nella foto 2) degna di nota, perché si tratta di un’antica vasca termale circolare di granito rosso che nel 1580, per volontà del cardinale Alessandro Farnese, fu collocata nella Piazza S.Marco, presso il Palazzetto Venezia, per sostituire la bella vasca termale trasferita a Piazza Farnese per essere riunita e fare coppia con quella già preesistente. Dopo il tentativo di Giacomo Della Porta di ornare la fontana di S.Marco con la statua di Marforio, la vasca venne addossata direttamente al Palazzetto Venezia ed ornata con un’edicola marmorea. Verso il 1860 fu trasferita al Pincio e poi di nuovo spostata, anche se di poco, nell’attuale posizione nel 1941: inserita al centro di un vasto bacino circolare, rialzato da terra, con ampio bordo arrotondato in travertino, presenta al centro un’anonima vasca di cemento adorna di due teste di leone sui lati lunghi.

La nostra visita prosegue e per una breve rampa arriviamo al Piazzale Napoleone I, in ricordo dell’imperatore francese che diede l’impulso per l’abbellimento del Pincio: dalla grande terrazza qui situata possiamo ammirare uno dei panorami più belli e famosi di Roma (nella foto 3) con Piazza del Popolo in primo piano.

Le sottostanti sostruzioni della terrazza ospitano la bellissima e scenografica fontana-mostra dell’Acqua Vergine (nella foto 4), costituita da una costruzione a due piani. Il piano inferiore presenta una parete con tre nicchie poco profonde, alle cui basi vi sono altrettante vaschette con uno zampillo centrale. Il piano superiore è formato invece da una loggia a tre archi preceduta da un colonnato: quattro colonne corinzie sono poste rispettivamente alle estremità della costruzione ed a ridosso dei due pilastri centrali di sostegno, mentre l’acqua sgorga da ampi zampilli all’interno delle tre arcate. Nel giugno 1878 fu collocata una statua di Vittorio Emanuele II all’interno dell’arcata centrale, poi rimossa nel 1936, quando venne sostituita con l’attuale mostra dell’Acquedotto Vergine, ideata dall’architetto Raffaele de Vico.

Una delle caratteristiche più interessanti del Parco del Pincio è senza dubbio l’obelisco egizio (nella foto 5) conosciuto come Obelisco Pinciano ma più correttamente deve dirsi di Antinoo, perché dedicato dall’imperatore Adriano al suo giovane amico annegato nel Nilo nel 130 d.C., forse per salvare l’imperatore stesso. Il monolite, realizzato per volere di Adriano, fu collocato sul monumento funebre di Antinoo che, secondo una recente ipotesi, doveva trovarsi all’interno degli Adonea sul Palatino: la scritta, in stile egizio, è dunque di mano romana. L’obelisco venne trasferito poi da Eliogabalo nel Circo Variano dove fu ritrovato nel XVI secolo: nel 1633 Urbano VIII lo fece trasportare nei giardini di Palazzo Barberini dove vi rimase fino al 1773, quando Cornelia Barberini lo donò a Clemente XIV che lo depositò nel cortile della Pigna in Vaticano. Fu per volontà di Pio VII che l’obelisco, alto metri 9,25, fu trasportato ed innalzato nella posizione attuale il 22 agosto 1822 dall’architetto Giuseppe Marini.

Un fascino particolare lo ha, indiscutibilmente, l’idrocronometro (nella foto 6) sistemato in Via dell’Orologio, presentato all’Esposizione di Parigi nel 1867, dove riscosse molto successo: ideatore fu un eminente meccanico orologiaio, il monaco domenicano Giovanni Battista Embriaco. L’orologio, collocato sopra una formazione rocciosa posta in mezzo ad un laghetto artificiale, è costituito da una torretta quadrangolare, con pareti in vetro, alla sommità della quale vi sono quattro quadranti di orologio, uno su ciascun lato: tutto il complesso venne qui collocato nel 1873 su progetto dell’architetto Gioacchino Ersoch. L’orologio funziona mediante un meccanismo nel quale l’acqua, riempiendo alternativamente due bacinelle, dà impulso al pendolo che carica il movimento degli ingranaggi e conseguentemente della suoneria. I quadranti sono molto semplici, con numeri neri romani su fondo bianco. Nel 2007 fu sottoposto a restauro ma purtroppo oggi l’idrocronometro è di nuovo non funzionante.

Un’altra bella fontana, situata in asse col belvedere di Piazzale Napoleone I, è la Fontana del Mosè (nella foto 7), costituita da un ampio bacino circolare al centro del quale si trova una statua marmorea femminile, chinata sull’acqua nell’atto di raccogliere la cesta di vimini all’interno della quale vi è posto un bambino seminascosto dal fogliame. Il gruppo, attribuito al conte Ascanio di Brazzà, è collocato sopra una scogliera sulla quale si ergono tre zampilli e raffigura la leggenda del piccolo Mosè salvato dalle acque dalla figlia del Faraone.

Quasi per scherzare con uno degli eventi più tragici della storia, riducendolo ad un giocattolo architettonico destinato agli incontri mondani, fu costruita la Casina Valadier, secondo la tradizione tale e quale, per forma e grandezza, al cassero della nave comandata dall’ammiraglio Horatio Nelson nella battaglia di Trafalgar che guidò la flotta britannica alla vittoria contro le flotte combinate franco-spagnole, assicurando il dominio navale britannico sulle acque del Mediterraneo. La graziosa costruzione neoclassica (nella foto 8) fu costruita da Giuseppe Valadier, da cui il nome, tra il 1813 ed il 1817 nel contesto della ristrutturazione del Pincio, trasformando una palazzina già del cardinale della Rota. L’edificio, situato sopra una cisterna romana appartenente al complesso degli Horti Aciliani, presenta un corpo cubico al quale è addossata un’esedra con colonnato ionico. Il casino fu concesso dal cardinale Rivarola, presidente della commissione pontificia per i lavori pubblici, ad Antonio Antonini, che fu il primo gestore del locale pubblico come caffetteria. Il casino divenne un locale alla moda dopo la Prima Guerra Mondiale, quando ne ebbe la gestione Alfredo Banfi: fu un luogo di ritrovo caratteristico, frequentato da artisti e politici. Alla morte del Banfi, nel 1964, la gestione passò a Mario De Monte, il quale ne curò il restauro. Chiuso nuovamente negli anni Settanta, in seguito riprese la sua attività di caffè e ristorante. Agli inizi degli anni 2000, dopo un breve periodo di chiusura, la Casina Valadier è stata completamente restaurata ed oggi è una delle location più ambite per matrimoni, ricevimenti e conferenze.