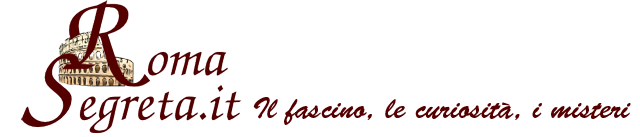Via Merulana prende il nome dai cosiddetti prata Meruli, o campus Meruli, un possedimento della famiglia Merula (o Meruli o Merli) che occupava tutta la zona tra il Laterano e la Basilica di S.Maria Maggiore. Il tracciato primitivo della via era ben diverso da quello attuale, in quanto partiva in prossimità dell’incrocio tra le odierne vie Labicana e Merulana, tagliava quest’ultima per dirigersi quasi verticalmente verso la zona oggi occupata da Piazza Vittorio Emanuele II, sfiorando Piazza Dante ad ovest e congiungendosi con la via che usciva dalla Porta Esquilina, ovvero l’antica Via Labicana. L’attuale Via Merulana invece fu aperta da Gregorio XIII e completata da Sisto V per collegare le due basiliche di S.Maria Maggiore e di S.Giovanni in Laterano: oggi segna il confine tra i Rioni Monti ed Esquilino, per cui il lato orientale appartiene al Rione Esquilino, mentre il lato occidentale appartiene al Rione Monti.
Prendiamo ora in considerazione la zona di appartenenza al Rione Esquilino.
La parte meridionale della via, in prossimità della Basilica di S.Giovanni in Laterano, ospita la Basilica di S.Antonio da Padova al Laterano (nella foto in alto sotto il titolo). La chiesa fu costruita, insieme all’annesso convento, per l’Ordine dei Frati Minori sull’area precedentemente occupata dal parco di Villa Giustiniani Massimo, a seguito dell’espulsione dei frati dalla loro storica sede dell’Aracoeli per consentire la costruzione del Monumento a Vittorio Emanuele II. Il progetto del complesso religioso fu affidato all’architetto Luca Carimini che lo realizzò tra il 1884 ed il 1887. Una doppia scalinata, anticipata da una cancellata in ferro battuto, conduce al monumentale portico sostenuto da pilastri con semicolonne, sopra le quali corre un fregio con triglifi e metope ornate con i simboli dell’ordine francescano. Al di sopra del porticato svetta una parete in laterizio divisa in due ordini: quello inferiore presenta cinque grandi finestre ad arco con vetrate policrome, quello superiore, invece, più stretto, presenta un oculo centrale, affiancato da due finestre ad arco, ed è concluso da un timpano con croce in marmo.

Sotto il portico, dove è situata la statua di S.Antonio con il Bambino Gesù in braccio (nella foto 1), si aprono tre porte di accesso alla chiesa, due laterali con timpano ed una centrale, bellissima, affiancata da lesene ornate da elementi vegetali e con capitelli a mensola: sopra un arco a tutto sesto, ornato da acroteri con palmette e rosette, è situata, all’interno della lunetta, la raffigurazione di S.Antonio in una gloria di angeli. L’interno è a tre navate, divise da colonne di granito rosa: quella centrale è più alta perché sopra è posto il matroneo, mentre in quelle laterali si aprono piccole cappelle rettangolari. In fondo alle navate si aprono le cappelle dedicate a S.Antonio, a destra, ed al Ss.Sacramento, a sinistra, quest’ultima fiancheggiata da due angeli che sostengono candelieri.

Le aumentate esigenze dell’Ordine comportarono, tra il 1930 ed il 1955, un notevole aumento del complesso prima con la costruzione di tre ali nell’area del giardino verso Viale Manzoni come sede della Pontificia Università Antonianum (nella foto 2 l’ingresso) ad opera dell’ingegnere Enrico Campa, ed in seguito con l’Aula Magna, la Biblioteca e le nuove aule su progetto di Mario Paniconi e Giulio Pediconi. L’attività accademica prese avvio, con la benedizione di Leone XIII, il 20 novembre 1890; il 17 maggio 1933, Pio XI, con decreto della Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, dichiarò canonicamente eretto l’Athenaeum Antonianum de Urbe (il titolo di ateneo pontificio sarebbe giunto il 14 giugno 1938), autorizzato a conferire i gradi accademici di baccalaureato, licenza e dottorato grazie alle facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia. L’11 gennaio 2005, infine, dopo l’erezione della Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, già incorporata nella Facoltà di Teologia come Studium Biblicum Franciscanum, Giovanni Paolo II concesse al Pontificio Ateneo Antonianum il titolo di università pontificia.

La parte settentrionale della via, invece, ospita, all’incrocio con Via di S.Vito, la chiesa di S.Alfonso all’Esquilino (nella foto 3), il fondatore dell’Ordine dei Redentoristi. La chiesa, eretta nel 1859 da George Wigley in forma neogotica e ristrutturata con ampie modifiche nel 1900 da Maximilian Schmalzl, è racchiusa all’interno di una recinzione che si apre con un cancello principale in ferro battuto sostenuto da pilastri in travertino, e due ingressi minori ai lati. La facciata, preceduta da una ripida scalinata, è in laterizio, ad eccezione dei tre portali, che si aprono in avancorpo, che sono in travertino. Il corpo centrale, nella parte superiore, è affiancato da due lesene dalle quali parte il grande arco a sesto acuto, inquadrato da un tetto a capanna e con un grande rosone al centro, chiuso da una bella vetrata policroma. I tre portali in travertino presentano ognuno un bassorilievo: quello centrale raffigura la Madonna del Perpetuo Soccorso con ricco contorno di angeli, mentre quelli laterali S.Alfonso de’ Liguori a sinistra e S.Clemente Hofbauer (dell’Ordine dei Redentoristi) a destra. Sulla cuspide del portale centrale è situata una statua del Redentore.

L’interno, a tre navate, è riccamente decorato con marmi e mosaici: sull’altare maggiore si trova la venerata immagine della Madonna del Perpetuo Soccorso (nella foto 4), dipinta su tavola ed attribuita con probabilità al XIV secolo. Questa venerata immagine fu trasportata qui dall’isola di Creta intorno al 1495 e posta nella chiesa di S.Matteo Apostolo, che era situata all’incrocio tra le odierne Via Merulana e Via Alfieri. Nel 1799, demolita la chiesa, l’immagine fu trasferita inizialmente nel monastero di S.Eusebio, poi nel convento di S.Maria in Posterula (un tempo situata presso Via dell’Orso, in corrispondenza dell’odierna Piazza di Ponte Umberto I e demolita per la costruzione dei muraglioni del Tevere) ed infine, nel 1866, nella chiesa di S.Alfonso all’Esquilino.